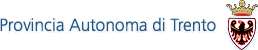Aree protette
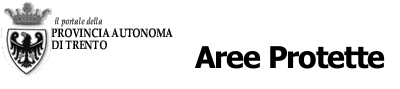

Notizie
-
12.10.2023
Lago di Toblino: chiusa la passerella pedonabile dal 16 ottobreDa lunedì 16 ottobre fino ad ultimazione lavori rimarrà chiuso un tratto della passerella-sentiero lungo la riva occidentale del Lago di Toblino, per interventi di manutenzione straordinaria e valorizzazione ambientale.
-
7.7.2023
Piano del Parco Nazionale dello Stelvio: adozione definitiva a seguito dell'intesa del Comitato provinciale di coordinamento e indirizzoAdottato in via definitiva il piano del Parco Nazionale dello Stelvio, acquisita nei mesi scorsi l'intesa del Comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo.
-
13.6.2023
Reti di Riserve: strategie ed opportunità per il riavvioA dieci anni dal loro avvio, le recenti modifiche alla disciplina delle Reti di Riserve hanno ridefinito parzialmente la cornice per il loro funzionamento. In un recente incontro sono stati illustrati punti di forza e di debolezza, ma anche i possibili sviluppi futuri.
-
1.6.2023
Geotrail, il viaggio interattivo nella geologia delle DolomitiScoprire le montagne patrimonio dell’umanità attraverso un’esperienza interattiva, alla portata di tutti. È ciò che offre il portale Dolomites World Heritage Geotrail, lo strumento – ora online – che permette di “leggere” in modo semplice e multimediale la geologia delle Dolomiti, in un viaggio lungo le ere geologiche che hanno plasmato questo territorio unico al mondo.
-
12.5.2023
Parco Nazionale dello Stelvio-Trentino: via libera al Programma degli interventi per il triennio 2023-2025Approvato dalla Giunta provinciale il programma degli interventi per il triennio 2023-2025 del settore Trentino del Parco Nazionale dello Stelvio, da realizzare anche in collaborazione con la Comunità di Valle e i comuni interessati.
-
15.4.2023
Rete di riserve Val di Cembra Avisio: rinnovata la convenzioneClima di festa ieri al rifugio malga Sauch, nel comune di Giovo, per il rinnovo della convenzione che istituisce la Rete di riserve val di Cembra Avisio.
6230 - * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)
* Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
* Species-rich Nardus grasslands, on silicious substrates in mountain areas (and submountain areas in Continental Europe)

Caratteristiche generali dell'habitat
Habitat caratterizzato da formazioni erbacee perenni chiuse, asciutte o mesofile, ricche di specie e con nardo dominante, che si sviluppano sui suoli silicei nelle regioni atlantiche, subatlantiche e boreali, dalle basse pianure alle regioni collinari e montane. Nelle Alpi, queste comunità sono quasi sempre diffuse a quote più elevate, fino a livello subalpino. Non raramente i nardeti sono sviluppati anche su suoli relativamente profondi (dilavati e decarbonatati) originatisi da substrati a matrice carbonatica, specialmente se marnoso-terrigena. Di fatto questo tipo include oltre ai nardeti le comunità acidofile ad essi affini. Le indicazioni del manuale sono molto chiare ed escludono che si possano attribuire a questo habitat, considerato prioritario, le situazioni irreversibilmente degradate generate dall’eccessivo carico pascolante.
Variabilità, contatti e criteri interpretativi
Il riconoscimento dei nardeti, di qualsiasi tipo, non comporta difficoltà interpretative, trattandosi di un gruppo di specie ben segregato e identificabile. I nardeti montani sono riferiti all’ordine Nardetalia (qualche autore riconosce anche una classe Nardetea, distinguendola da Calluno-Ulicetea), complessivamente poco variabile nelle regioni dell’Italia nordorientale, fatto comprensibile trattandosi di un’unità a gravitazione subatlantica. Come riferito in 6150, le comunità ricche di nardo, localizzate ad alta quota, sopra il limite della foresta, appartengono all’alleanza Nardion della classe Caricetea curvulae e, pertanto, vanno ad esso riferite. Tra gli aspetti interessanti, e talvolta molto ricchi di specie, si possono menzionare quelli a Festuca paniculata, spesso derivanti da fasi di abbandono del pascolo estensivo sui versanti soleggiati. Frequenti sono, a quota montana, i contatti con praterie magre di 6210, oppure con situazioni più igrofile tendenti ai molinieti (6410).
Specie vegetali tipiche
Dominanti:
Nardus stricta, Agrostis tenuis, Anthoxanthum odoratum, Avenella flexuosa, Festuca nigrescens.
Caratteristiche:
Antennaria dioica, Arnica montana, Campanula barbata, Carex pallescens, Carex pilulifera, Chamaespartium sagittale (EN), Danthonia decumbens, Galium pumilum, Gnaphalium sylvaticum, Hieracium aurantiacum, Hieracium hoppeanum, Hieracium lactucella, Hieracium pilosella, Holcus mollis (NT), Hypochoeris maculata (NT), Luzula campestris agg., Melampyrum pratense, Polygala vulgaris, Pseudorchis albida, Veronica officinalis, Viola canina.
Altre:
Botrychium lunaria, Botrychium matricariifolium (CR), Briza media, Calluna vulgaris, Carex leporina, Carlina acaulis, Cirsium acaule, Crepis aurea, Dactylorhiza sambucina, Deschampsia caespitosa (aspetti umidi e degradati), Diphasiastrum complanatum (EN), Festuca tenuifolia, Gentiana acaulis, Geum montanum, Gymnadenia conopsea, Homogyne alpina, Hypericum maculatum, Meum athamanticum (EN*), Molinia caerulea, Nigritella nigra, Peucedanum carvifolia (VU), Phleum rhaeticum, Poa alpina, Potentilla aurea, Potentilla erecta, Rhinanthus minor, Scorzonera humilis, Thymus pulegioides, Trisetum flavescens, Vaccinium myrtillus.
Estinte:
Botrychium lanceolatum §, Botrychium multifidum §.
Distribuzione in provincia
Pur essendo considerato un habitat prioritario, esso è stato censito nella maggioranza dei siti provinciali, con un’apprezzabile superficie.
Dinamismo naturale
Con la sola eccezione di quelli primari extrasilvatici, che non rientrano in questo codice, i nardeti sono praterie di origine secondaria, almeno a livello alpino. Essi possono essre mantenuti dalle pratiche colturali. Tradizionalmente il pascolo prevale sulla falciatura ma non deve essere troppo intensivo. In assenza di cure colturali l’evoluzione è verso la brughiera nelle zone più asciutte e ventose e verso l’affermazione del bosco di conifere (abete rosso e pino silvestre). A quote collinari e submontane, situazione rara in Trentino, la vegetazione potenziale su terreni magri e acidi sarebbe rappresentata da comunità di Quercion robori-petraeae in cui, localmente, betulle e castagni possono essere prevalenti. Tra gli stadi di rimboschimento naturale, olte ai nuclei di betulla, si osservano quelli a pioppo tremulo, raramente con noccioli e/o tigli. A quote subalpine, in stazioni innevate, si possono sviluppare i rodoro-vaccinieti (4060) e le alnete a ontano verde. Stadi di degradazione conseguenti all’abbandono dopo un eccessivo pascolamento posssono favorire ginepri e rose di macchia (5130).
Note ed osservazioni
Un’interpretazione troppo letterale della priorità attribuita a questo habitat in ambito europeo produrrebbe distorsioni pericolose della stessa finalità cui è ispirata la direttiva habitat, cioè quella di conservare e tutelare la biodiversità. In particolare il caso limite può essere rappresentato da un pascolo umido con nuclei di torbiera basifila (7230) o di transizione (7140). Poiché gli habitat torbicoli sopraccitati non sono considerati prioritari, mentre lo è il nardeto, si potrebbe ipotizzare che un drenaggio praticato per favorire il pascolo a nardo sarebbe auspicabile. Non è necessario essere esperti geobotanici per comprendere come in ambiente alpino (quanto meno) le zone umide torbose siano ecologicamente assai più rilevanti dei nardeti, a prescindere dalla priorità accordata a 6230.
Vulnerabilità e indicazioni gestionali
Il pascolamento tradizionale, purché non eccessivo, è la condizione fondamentale per la conservazione di questo habitat. In Alto Adige è diffuso, ancor oggi, anche lo sfalcio che ha il pregio di rendere queste praterie paesaggisticamente molto più attraenti e di aumentare il numero di specie presenti nel popolamento. In Trentino la falciatura era praticata in passato (M. Gazza, M. Bondone, Finonchio, Folgaria, Pasubio, ecc.), ma è oggi quasi ovunque abbandonata, con conseguente deciso impoverimento floristico. Variazioni di composizione floristica sono determinate quasi sempre dalle modalità gestionali piuttosto che dai fattori naturali e contribuiscono comunque al mantenimento della biodiversità. I prati di bassa quota sono più vulnerabili e soggetti all’avanzata del bosco. A livello subalpino il processo è più lento e il mosaico nardeto-rodoreto (con parchi di larici nelle adiacenze) è una delle note peculiari del paesaggio, specialmente nei settori a substrato siliceo prevalente.
- IT3120001 - Alta Val di Rabbi
- IT3120002 - Alta Val La Mare
- IT3120003 - Alta Val del Monte
- IT3120015 - Tre Cime Monte Bondone
- IT3120018 - Scanuppia
- IT3120020 - Palù Longa
- IT3120024 - Zona Umida Valfloriana
- IT3120027 - Canzenagol
- IT3120032 - I Mughi
- IT3120036 - Redebus
- IT3120045 - Lagabrun
- IT3120046 - Prati di Monte
- IT3120047 - Paluda La Lot
- IT3120050 - Torbiera delle Viote
- IT3120056 - Palù Longia
- IT3120058 - Torbiere di Monte Sous
- IT3120064 - Torbiera del Tonale
- IT3120092 - Passo del Broccon
- IT3120093 - Crinale Pichea - Rocchetta
- IT3120094 - Alpe di Storo e Bondone
- IT3120095 - Bocca d'Ardole - Corno della Paura
- IT3120097 - Catena di Lagorai
- IT3120104 - Monte Baldo - Cima Valdritta
- IT3120106 - Nodo del Latemar
- IT3120107 - Val Cadino
- IT3120112 - Arnago
- IT3120119 - Val Duron
- IT3120127 - Monti Tremalzo e Tombea
- IT3120128 - Alta Val Stava
- IT3120142 - Val Campelle
- IT3120143 - Valle del Vanoi
- IT3120154 - Le Sole
- IT3120165 - Vermiglio - Folgarida
- IT3120166 - Rè di Castello Breguzzo
- IT3120167 - Torbiere Alta Val Rendena
- IT3120168 - Lagorai Orientale - Cima Bocche
- IT3120169 - Torbiere del Lavazè
- IT3120171 - Muga Bianca - Pasubio
- IT3120173 - Monte Baldo di Brentonico
- IT3120174 - Monte Remà - Clevet
- IT3120175 - Adamello
- IT3120176 - Monte Sandron
- IT3120177 - Dolomiti di Brenta
- IT3120178 - Pale di San Martino
- IT3120100 - Pasubio
- IT3120157 - Stelvio
- IT3120158 - Adamello-Presanella
- IT3120159 - Brenta
- IT3120160 - Lagorai
- 6230