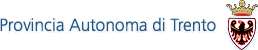Aree protette
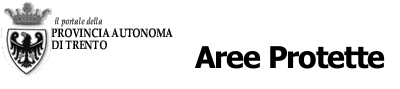

Notizie
-
12.10.2023
Lago di Toblino: chiusa la passerella pedonabile dal 16 ottobreDa lunedì 16 ottobre fino ad ultimazione lavori rimarrà chiuso un tratto della passerella-sentiero lungo la riva occidentale del Lago di Toblino, per interventi di manutenzione straordinaria e valorizzazione ambientale.
-
7.7.2023
Piano del Parco Nazionale dello Stelvio: adozione definitiva a seguito dell'intesa del Comitato provinciale di coordinamento e indirizzoAdottato in via definitiva il piano del Parco Nazionale dello Stelvio, acquisita nei mesi scorsi l'intesa del Comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo.
-
13.6.2023
Reti di Riserve: strategie ed opportunità per il riavvioA dieci anni dal loro avvio, le recenti modifiche alla disciplina delle Reti di Riserve hanno ridefinito parzialmente la cornice per il loro funzionamento. In un recente incontro sono stati illustrati punti di forza e di debolezza, ma anche i possibili sviluppi futuri.
-
1.6.2023
Geotrail, il viaggio interattivo nella geologia delle DolomitiScoprire le montagne patrimonio dell’umanità attraverso un’esperienza interattiva, alla portata di tutti. È ciò che offre il portale Dolomites World Heritage Geotrail, lo strumento – ora online – che permette di “leggere” in modo semplice e multimediale la geologia delle Dolomiti, in un viaggio lungo le ere geologiche che hanno plasmato questo territorio unico al mondo.
-
12.5.2023
Parco Nazionale dello Stelvio-Trentino: via libera al Programma degli interventi per il triennio 2023-2025Approvato dalla Giunta provinciale il programma degli interventi per il triennio 2023-2025 del settore Trentino del Parco Nazionale dello Stelvio, da realizzare anche in collaborazione con la Comunità di Valle e i comuni interessati.
-
15.4.2023
Rete di riserve Val di Cembra Avisio: rinnovata la convenzioneClima di festa ieri al rifugio malga Sauch, nel comune di Giovo, per il rinnovo della convenzione che istituisce la Rete di riserve val di Cembra Avisio.
8240 - * Pavimenti calcarei
* Kalk-Felspflaster
* Limestone pavements

Caratteristiche generali dell'habitat
La descrizione fornita dal manuale, per questo habitat prioritario, è molto articolata e fondata sulle situazioni presenti nelle Isole Britanniche e in Scandinavia che, in parte, si sintetizzano qui. Lastre di pietra mobili e blocchi regolari di calcare con fessure verticali. La superficie rocciosa è scarsamente ricoperta da suolo e quindi la vegetazione è rada, coprendo in generale meno del 50%. Localmente si formano sacche di terreno che consentono lo sviluppo di molte specie diverse di piante, dalle fanerofite alle terofite. La vegetazione, condizionata dai diversi microclimi, è a mosaico e quindi difficilmente tipificabile. Le piante sciafile prediligono le fessure, mentre in superficie si sviluppano, sia specie di 6210 che di 6170 ma anche numerose specie arbustive di macchia e/o brughiera. Importante è la componente crittogamica con briofite e licheni.
Variabilità, contatti e criteri interpretativi
Ad un’interpretazione restrittiva e letterale del manuale, questo tipo di habitat non interesserebbe l’arco alpino, Tuttavia, la descrizione geomorfologica da un lato, nonché le indicazioni fornite dalla Società Botanica Italiana fin dal periodo in cui si schedavano i siti secondo il progetto Bioitaly, inducono a confermarne la sua effettiva presenza, seguendo l’esempio anche di altre regioni limitrofe. D’altra parte i siti sono stati ufficialmente approvati e ciò rappresenta un’ulteriore motivazione per valutare tale habitat in senso più flessibile, considerando le peculiarità del territorio alpino in cui i fenomeni carsici svolgono un ruolo importante. Di fatto, nelle nostra provincia, i pavimenti calcarei sono diffusi anche negli altopiani e interessano ambienti a quote variabili da submontane a subnivali. Nelle fessure delle rocce sono diffuse le comunità sciafile con muschi, felci, Geranium robertianum, Aconitum sp., Adenostyles, Viola biflora ecc. Sulla superficie, invece, prevalgono aspetti riconducibili a xerobrometi, seslerieti, firmeti, stadi a Dryas octopetala. In stazioni a lungo innevamento partecipano alla comunità anche elementi di Arabidion. Tra i cespugli gli aspetti più frequenti sono quelli a ginepro nano, rododendro irsuto ed altre ericacee (ma in tal caso il codice di riferimento è 4060), mentre a quote basse gli elementi di Prunetalia sono a contatto con formazioni di 5130. A bassa quota risultatno evidenti i contatti con le comunità dei seslerio-brometi.
Specie vegetali tipiche
Dominanti:
Carex firma, Cystopteris fragilis, Dryas octopetala, Festuca pumila, Salix retusa, Salix serpillifolia. Cotinus coggygria (stazioni termofile).
Caratteristiche:
Aconitum tauricum, Daphne alpina,Dryopteris villarii, Polystichum lonchitis, Sempervivum dolomiticum (DD), Scabiosa graminifolia, Sesleria sphaerocephala.
Altre:
Adenostyles glabra, Amelanchier ovalis, Arctostaphylos uva-ursi,Asplenium ruta-muraria, Asplenium viride, Bromus erectus ssp. condensatus, Calamagrostis varia, Carex humilis, Cotoneaster tomentosus, Erica carnea, Euphrasia tricuspidata, Fraxinus ornus,Geranium macrorrhizum (VU), Geranium robertianum, Globularia cordifolia, Gymnocarpium robertianum, Iris cengialti (NT). Juniperus nana, Ostrya carpinifolia, Pinus sylvestris, Potentilla caulescens, Rhamnus pumilus, Rhamnus saxatilis,Rhododendron hirsutum, Rosa pendulina,Sesleria caerulea, Valeriana tripteris, Viola biflora. Importanti la componente briofitica e i licheni.
Distribuzione in provincia
L’habitat è stato censito e cartografato in poco più di una decina di siti. Attribuendo all’habitat anche caratteristiche microterme, la sua presenza è da estendere anche in stazioni di alta quota, in corrispondenza di lastroni calcarei suborizzontali e poco colonizzati, ad esempio nel SIC del Monte Tremalzo e, soprattutto, nei pianori glacio-carsici delle Pale di San Martino e al Grosté nelle Dolomiti di Brenta.
Dinamismo naturale
Per le caratteristiche dell’habitat le possibilità evolutive restano scarse, ma laddove è stata avviata una colonizzazione da parte di arbusti essi possono arrivare a pescare acqua e sali minerali nelle sacche di terreno più profondo ed espandere quindi le loro fronde sulla superficie libera della roccia avviando il lento processo che consentirà poi lo sviluppo di piante più esigenti. Si tratta in ogni caso di mosaici a lenta evoluzione e pertanto sostanzialmente stabili. Le variazioni microclimatiche generano fenomeni di compensazione interna. Per quanto concerne le quattro stazioni termofile già identificate in Trentino, esse sono esposte al pericolo di incendio, che può far regredire l’evoluzione del suolo a stadi più primitivi.
Note ed osservazioni
Più che i caratteri della vegetazione, sono importanti i parametri geomorfologici. Spesso è rilevante, infatti, il loro valore paesaggistico.
Vulnerabilità e indicazioni gestionali
Si tratta di ambienti lasciati quasi sempre all’evoluzione naturale, assai raramente soggetti a pascolo estensivo (solo al margine, essendo pericoloso per gli animali domestici superare le fessure).
- 8240