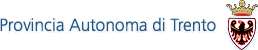Aree protette
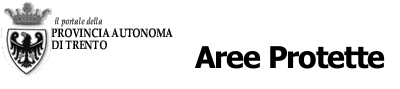

Notizie
-
12.10.2023
Lago di Toblino: chiusa la passerella pedonabile dal 16 ottobreDa lunedì 16 ottobre fino ad ultimazione lavori rimarrà chiuso un tratto della passerella-sentiero lungo la riva occidentale del Lago di Toblino, per interventi di manutenzione straordinaria e valorizzazione ambientale.
-
7.7.2023
Piano del Parco Nazionale dello Stelvio: adozione definitiva a seguito dell'intesa del Comitato provinciale di coordinamento e indirizzoAdottato in via definitiva il piano del Parco Nazionale dello Stelvio, acquisita nei mesi scorsi l'intesa del Comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo.
-
13.6.2023
Reti di Riserve: strategie ed opportunità per il riavvioA dieci anni dal loro avvio, le recenti modifiche alla disciplina delle Reti di Riserve hanno ridefinito parzialmente la cornice per il loro funzionamento. In un recente incontro sono stati illustrati punti di forza e di debolezza, ma anche i possibili sviluppi futuri.
-
1.6.2023
Geotrail, il viaggio interattivo nella geologia delle DolomitiScoprire le montagne patrimonio dell’umanità attraverso un’esperienza interattiva, alla portata di tutti. È ciò che offre il portale Dolomites World Heritage Geotrail, lo strumento – ora online – che permette di “leggere” in modo semplice e multimediale la geologia delle Dolomiti, in un viaggio lungo le ere geologiche che hanno plasmato questo territorio unico al mondo.
-
12.5.2023
Parco Nazionale dello Stelvio-Trentino: via libera al Programma degli interventi per il triennio 2023-2025Approvato dalla Giunta provinciale il programma degli interventi per il triennio 2023-2025 del settore Trentino del Parco Nazionale dello Stelvio, da realizzare anche in collaborazione con la Comunità di Valle e i comuni interessati.
-
15.4.2023
Rete di riserve Val di Cembra Avisio: rinnovata la convenzioneClima di festa ieri al rifugio malga Sauch, nel comune di Giovo, per il rinnovo della convenzione che istituisce la Rete di riserve val di Cembra Avisio.
9170 - Querceti di rovere del Galio-Carpinetum
Eichen-Hainbüchenwäldern der Galio-Carpinetum
Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests
Caratteristiche generali dell'habitat
Rispetto a 9160, con querce e carpino bianco che restano le specie guida dominanti, questo habitat è caratterizzato da suoli meno umidi e dalla netta prevalenza della rovere. Esso interessa le regioni a clima subcontinentale comprese nell’areale centroeuropeo del faggio. In tale tipo si dovrebbero comprendere anche comunità simili diffuse nell’Europa centro-orientale, con clima continentale, situate a oriente del limite di distribuzione del faggio.
Variabilità, contatti e criteri interpretativi
La corrispondenza con comunità di Galio-Carpinetum è espressamente nominata nel titolo del codice e appare dunque tassativa. Pedrotti & Gafta (1999) accertano la presenza di Galio laevigati-Carpinetum in Trentino, con 11 rilievi eseguiti su substrati silicei e detriti morenici. Nello stesso contributo essi descrivono anche Luzulo niveae-Quercetum petraeae, pure diffuso sui substrati silicatici. Sfortunatamente, per i boschi acidofili di rovere sudalpini (senza carpino bianco), che pure sono di rilevante valore fitogeografico, non sono previsti specifici codici habitat. In assenza di alternative, considerata la più che dubbia praticabilità di poterli riferire ai boschi pannonici (prioritari) del codice 91G0 (che pure prevede la compartecipazione del carpino bianco), si potrebbe proporre un’interpretazione più estensiva al fine di far rientrare, senza creare un nuovo codice, per evidenti affinità ecologiche e fitogeografiche, tali boschi di rovere in questo tipo. La differenza tra comunità di Quercetalia robori-petraeae e Carpinion (Fagetalia) non sembra quindi motivo sufficiente per l’attribuzione a 9160 o a 9170 rispettivamente. Più che la sintassonomia dovrebbe essere considerata, in Trentino dove il clima varia da insubrico e submediterraneo a subcontinentale, la capacità di ritenzione idrica dei suoli, associata alla geomorfologia. Di norma i boschi di rovere si sviluppano su versanti ben drenati a quote superiori a quelle dei carpineti (localizzati a fondovalle).
Specie vegetali tipiche
Dominanti:
Carpinus betulus, Quercus petraea.
Caratteristiche:
Asarum eruropaeum, Festuca heterophylla, Galium laevigatum, Hieracium laevigatum, Hieracium racemosum, Hieracium sabaudum, Luzula nivea.
Altre:
Acer campestre, Aegopodium podagraria, Carex digitata, Carex montana, Carex umbrosa (NT), Clematis vitalba, Convallaria majalis, Corylus avellana, Cytisus scoparius, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus, Hieracium murorum, Lamium orvala, Lathyrus niger, Ligustrum vulgare, Melampyrum pratense, Mycelis muralis, Orobanche rapum-genistae (CR), Poa nemoralis, Polygonatum multiflorum, Prunus avium, Salvia glutinosa, Sorbus torminalis, Teucrium scorodonia, Tilia cordata, Vinca minor, Viola reichenbachiana.
Distribuzione in provincia
Tipo molto raro, censito originariamente solo nel sito Montepiano-Palù di Fornace su una modesta superficie. Ciò è comprensibile sia in relazione alla rarità intrinseca del tipo che al fatto che tali frammenti residuali sono inseriti spesso in ambiti molto antropizzati. Proprio per la frammentazione dell’habitat e la dubbia appartenenza al tipo come codificata dal manuale, si è ritenuto opportuno togliere dal database Natura 2000 anche la segnalazione per il sito sopraccitato. Il tipo è, comunque, sicuramente presente in Trentino
Dinamismo naturale
L’areale potenziale di qusto habitat è stato in gran parte sostituito da colture specializzate o occupato da insediamenti. Trattasi di formazione di notevole stabilità in cui la regolare ceduazione può favorire la permanenza del carpino bianco a scapito di rovere e/o faggio, assai competitivi nel lungo termine.
Note ed osservazioni
Sarebbe opportuna una puntuale ricognizione di questi frammenti, che rivestono un elevato significato fitogeografico e anche il tentativo di inserire tra i SIC o le ZPS altre aree in cui tale habitat sia meglio rappresentato, visto che in Italia sono soltanto 8 i siti individuati.
Non appare inutile, inoltre, richiamare l’attenzione sul fatto che nelle Alpi sudorientali, una distinzione netta tra popolazioni da riferire al gruppo di Quercus pubescens o a quello di Quercus petraea resta problematica.
Vulnerabilità e indicazioni gestionali
La gestione di questi relitti (preferibile quella ad alto fusto) è sempre complessa a causa della loro localizzazione in siti soggetti a notevoli pressioni per l’espansione delle attività antropiche. Una normale ceduazione, invece, potrebbe favorire l’ingresso della robinia, o del castagno, con conseguente degradazione della comunità a rovere, a meno di non intervenire in modo molto mirato ed accurato, evitando da un lato aperture eccessive e/o provvedendo in seguito, con adeguate cure colturali, ad agevolare lo sviluppo delle querce. Spesso si osservano nel sottobosco entità nitrofile che rivelano condizioni di degrado o di impoverimento causate dall’eutrofizzazione che, al contrario, dovrebbe essere limitata con adeguati provvedimenti.
- 9170