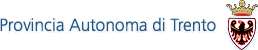Aree protette
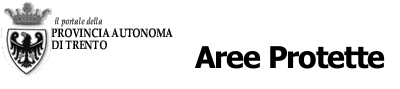

Notizie
-
12.10.2023
Lago di Toblino: chiusa la passerella pedonabile dal 16 ottobreDa lunedì 16 ottobre fino ad ultimazione lavori rimarrà chiuso un tratto della passerella-sentiero lungo la riva occidentale del Lago di Toblino, per interventi di manutenzione straordinaria e valorizzazione ambientale.
-
7.7.2023
Piano del Parco Nazionale dello Stelvio: adozione definitiva a seguito dell'intesa del Comitato provinciale di coordinamento e indirizzoAdottato in via definitiva il piano del Parco Nazionale dello Stelvio, acquisita nei mesi scorsi l'intesa del Comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo.
-
13.6.2023
Reti di Riserve: strategie ed opportunità per il riavvioA dieci anni dal loro avvio, le recenti modifiche alla disciplina delle Reti di Riserve hanno ridefinito parzialmente la cornice per il loro funzionamento. In un recente incontro sono stati illustrati punti di forza e di debolezza, ma anche i possibili sviluppi futuri.
-
1.6.2023
Geotrail, il viaggio interattivo nella geologia delle DolomitiScoprire le montagne patrimonio dell’umanità attraverso un’esperienza interattiva, alla portata di tutti. È ciò che offre il portale Dolomites World Heritage Geotrail, lo strumento – ora online – che permette di “leggere” in modo semplice e multimediale la geologia delle Dolomiti, in un viaggio lungo le ere geologiche che hanno plasmato questo territorio unico al mondo.
-
12.5.2023
Parco Nazionale dello Stelvio-Trentino: via libera al Programma degli interventi per il triennio 2023-2025Approvato dalla Giunta provinciale il programma degli interventi per il triennio 2023-2025 del settore Trentino del Parco Nazionale dello Stelvio, da realizzare anche in collaborazione con la Comunità di Valle e i comuni interessati.
-
15.4.2023
Rete di riserve Val di Cembra Avisio: rinnovata la convenzioneClima di festa ieri al rifugio malga Sauch, nel comune di Giovo, per il rinnovo della convenzione che istituisce la Rete di riserve val di Cembra Avisio.
Boschi ripariali
I boschi paludosi e ripariali, che fino agli inizi dello scorso secolo occupavano vaste superfici dei fondovalle del Trentino, sono stati praticamente cancellati dalle bonifiche e dalla canalizzazione dei fiumi.
Di questi ambienti oggi non rimangono che poche vestigia: sottili fasce sopravvissute qua e là lungo alcuni corsi d'acqua, impoverite nella composizione specifica e degradate dagli interventi dell'uomo; oppure qualche lembo scampato quasi miracolosamente alle bonifiche, trovandosi in aree non idonee ad essere coltivate, come le rive paludose dei laghi oppure le zone periodicamente inondate a fregio di corsi d'acqua.

Piante
Il principale tipo di bosco ripariale è quello di ontano nero (Alnus glutinosa), che si insedia in luoghi paludosi o comunque con falda freatica superficiale. In esso si possono rinvenire anche altre specie arboree, come il pioppo bianco (Populus alba), il pioppo nero (Populus nigra), il salice bianco (Salix alba) e l'ontano bianco (Alnus incana).
In questi boschi il terreno è molto ricco di sostanze nutritive e il sottobosco si presenta rigoglioso e ricco. Nello strato arbustivo si possono osservare la palla di neve (Viburnum opulus), la sanguinella (Cornus sanguinea) e la frangola (Frangula alnus); in situazioni di forte presenza di azoto nel terreno anche il sambuco (Sambucus nigra) e i rovi (Rubus spp.).
Tra le specie erbacee si possono facilmente rinvenire l'olmaria (Filipendula ulmaria), il giaggiolo giallo (Iris pseudacorus), il campanellino (Leucojum vernum), la Carexremota, la matricale (Stachys silvatica) e, presso i ruscelletti, la calta palustre (Caltha palustris). Un'altra specie caratteristica, anche se assai rara, è la felce palustre (Thelypteris palustris), che cresce solo in un particolare tipo di ontaneta.
L'ontano bianco può crescere anche nei boschi di ontano nero, ma rispetto a quest'ultima specie è decisamente meno igrofilo ed occupa quindi solo i settori di ontaneta caratterizzati da terreni ghiaiosi ben drenati. A volte dà invece origine a boschi ripariali propri, le ontanete a ontano bianco, nelle aree che insistono su riporti di materiali alluvionali, a fregio dei torrenti o dei fiumi.
In queste formazioni arboree il sottobosco è in genere assai meno ricco e rigoglioso rispetto a quanto si riscontra nelle ontanete a ontano nero.
I terreni paludosi e con substrato torboso sono gli ambienti in cui si possono sviluppare delle comunità vegetali molto rare e interessanti: gli arbusteti paludosi. Essi sono composti in prevalenza da Salix cinerea e secondariamente da frangola, mentre lo strato erbaceo è di regola costituito da specie palustri.
Anfibi
Nei boschi riparali la presenza di un elevato grado di umidità e della copertura offerta dallo strato arboreo facilita la presenza di alcune specie di Anfibi.
Nelle raccolte d'acqua che frequentemente occupano le depressioni del terreno o nei ruscelli che attraversano questi boschi le rane, i rospi e le salamandre depongono le uova o le larve.
Mammiferi
Non vi sono specie di mammiferi esclusive di questi ambienti, che cioè trovano in essi l'unico habitat per sopravvivere. Sono però numerose le entità che abitualmente frequentano i boschi riparali in quanto ambienti particolarmente tranquilli.
Va considerato che i boschi riparali si configurano spesso come "isole" di natura nell'ambito di fondovalle antropizzati e in tal modo rappresentano oasi di rifugio, alimentazione e riproduzione per molte specie della fauna selvatica, tra cui i Mammiferi, animali particolarmente sensibili al disturbo umano.
Pesci
n.d.
Rettili
I boschi riparali non sono ambienti particolarmente favorevoli alla presenza dei Rettili, in quanto il loro microclima è piuttosto fresco e i luoghi aperti adatti ad esporsi al sole sono limitati.
Le specie più comuni sono quindi quelle legate alla presenza dell'acqua, in particolare le natrici.
Uccelli
I boschi riparali sono di norma ambienti che presentano un'avifauna molto ricca e interessante. La maggiore varietà si riscontra soprattutto dove sono presenti alberi di grandi dimensioni forniti di un abbondante sottobosco.
In questi casi, oltre a numerose specie di piccoli Passeriformi canori, che nidificano tra i cespugli e nelle chiome, possono essere presenti uccelli di maggior taglia, come ad esempio i picchi o qualche rapace diurno o notturno.